TETTE FUORI, DELLA NUOVA CAMPAGNA DI CHEAP E DELL’IPOCRITA ALGORITMO DI FACEBOOK. UN’INTERVISTA A SARA MANFREDI.
 Seno, tette, pocce, minne, zinne, menne, sise, bocce, titte. Chiamatele come volete, ma ammettetelo: quando ne parliamo tendiamo a essere molto ipocrite. Noi, in parte, ma soprattutto la società nella quale stiamo vivendo.
Seno, tette, pocce, minne, zinne, menne, sise, bocce, titte. Chiamatele come volete, ma ammettetelo: quando ne parliamo tendiamo a essere molto ipocrite. Noi, in parte, ma soprattutto la società nella quale stiamo vivendo.
Pensateci bene: se dieci, venti anni fa sulle nostre spiagge potevamo vedere topless e, naturalmente, starci, oggi vediamo bambine costrette in reggiseni allo stesso tempo pudici e sessualizzanti.
Perché è questo il grande controsenso, una società dove il seno è contemporaneamente oggetto di piacere, frutto proibito e appetitoso, sbattuto in prima serata o sulle copertine, ma anche peccaminoso e da censurare. Soprattutto se parliamo di capezzoli. Soprattutto sui social.
Manco a dirlo però, vale solo per il seno delle donne.
Proprio su questa grande contraddizione si basa la nuova campagna di Cheap.
Ce la siamo fatta raccontare da una delle sue ideatrici, Sara Manfredi, e attraverso le fotografie di Margherita Caprili.
Come nasce l’idea di Tette fuori?
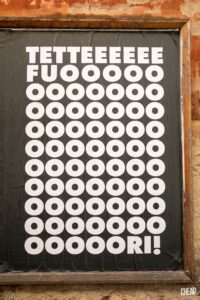 L’affissione è firmata in partnership con School of Feminism, piattaforma dedita all’attivismo e alla produzione di contenuti grafici, che torna in Italia con Cheap dopo aver già realizzato nel 2019 l’intervento di poster Ringrazia una femminista. Le grafiche, i testi e le fotografie che compongono i poster, sono tratte dal libro Pechos Fuera, edito nel 2020 in Spagna da Zenith: un testo in cui School of Feminism riprende in esame la rappresentazione dei seni nella storia dell’arte e nella comunicazione visiva più contemporanea, accompagnandola da una riflessione politica, sociale e iconografica. Cheap ha pensato a tradurre quei contenuti in poster per realizzarne un intervento di arte pubblica.
L’affissione è firmata in partnership con School of Feminism, piattaforma dedita all’attivismo e alla produzione di contenuti grafici, che torna in Italia con Cheap dopo aver già realizzato nel 2019 l’intervento di poster Ringrazia una femminista. Le grafiche, i testi e le fotografie che compongono i poster, sono tratte dal libro Pechos Fuera, edito nel 2020 in Spagna da Zenith: un testo in cui School of Feminism riprende in esame la rappresentazione dei seni nella storia dell’arte e nella comunicazione visiva più contemporanea, accompagnandola da una riflessione politica, sociale e iconografica. Cheap ha pensato a tradurre quei contenuti in poster per realizzarne un intervento di arte pubblica.
La sessualizzazione del corpo delle donne, nello specifico del seno, è un dato evidente. Eppure di fronte ad altre circostanze quali l’allattamento, il seno di una donna diventa da censurare. Perché secondo voi?
Temo sia il male gaze, lo sguardo maschile: uno sguardo che riduce le donne e i loro corpi a oggetti sessuali. Da una parte sei un sextoy e quindi vieni ipersessualizzata, dall’altra vieni colpevolizzata se dai una destinazione non erotica al tuo corpo: se servi al piacere maschile vieni spogliata, se ti spogli in un gesto di autodeterminazione vieni additata.
C’è seno e seno. La policy dei social media ha parametri diversi per quello maschile e quello femminile. Perché?
I social media e le loro simpatiche policy ricalcano questi modelli e a volte producono norme schizofreniche: i capezzoli, i seni, non sono organi sessuali; quelli degli uomini possono essere mostrati, quelli delle donne no. La censura dell’algoritmo sui nostri corpi agisce in secondi e produce la rimozione dei contenuti. Invece, se chiedi la rimozione di un contenuto sessista, razzista o xenofobo, la cosa non succede: ti senti rispondere che il contenuto «non viola gli standard della community», una dichiarazione di concussione.
Come nasce una campagna come questa e come le altre che l’hanno preceduta?
 I nostri interventi nascono da un desiderio, da un bisogno, dall’opportunità di iniziare una conversazione nello spazio pubblico con chi abita la città e la attraversa. Interveniamo in maniera diversa, utilizzando linguaggi visivi contemporanei per realizzare campagne, installazioni d’arte, progetti che rientrano nella macro categoria di arte pubblica. A volte operiamo come curatrici, selezionando progetti già realizzati e contestualizzandoli nella città, traducendoli in azioni site specific di intervento sul paesaggio urbano di Bologna. In altri casi, progettiamo i lavori da zero, esprimendo anche una direzione creativa e artistica, lavorando con le risorse e le competenze interne a Cheap, oppure coinvolgendo artistə visivə, graphic designer, fotografə e street artist.
I nostri interventi nascono da un desiderio, da un bisogno, dall’opportunità di iniziare una conversazione nello spazio pubblico con chi abita la città e la attraversa. Interveniamo in maniera diversa, utilizzando linguaggi visivi contemporanei per realizzare campagne, installazioni d’arte, progetti che rientrano nella macro categoria di arte pubblica. A volte operiamo come curatrici, selezionando progetti già realizzati e contestualizzandoli nella città, traducendoli in azioni site specific di intervento sul paesaggio urbano di Bologna. In altri casi, progettiamo i lavori da zero, esprimendo anche una direzione creativa e artistica, lavorando con le risorse e le competenze interne a Cheap, oppure coinvolgendo artistə visivə, graphic designer, fotografə e street artist.
Che cos’è e come nasce Cheap?
Cheap è un progetto di arte pubblica che interviene con poster o paste up sul paesaggio urbano di Bologna; è nata come un festival internazionale di street art di cui abbiamo realizzato cinque edizioni, poi abbiamo avuto il buon senso di diventare altro, un laboratorio permanente. Abbiamo scelto il nome Cheap perché crediamo che l’ironia sia una forma di intelligenza da coltivare. Per noi funziona come un memo per evitare di scivolare nella self mithology e prendere troppo sul serio il nostro lavoro. Ci occupiamo di arte pubblica e lo facciamo con la carta, il materiale più effimero che siamo riuscite a trovare, per molti il materiale più cheap a cui si possa pensare: questo ci posiziona in una prospettiva anti-monumentale e ha fatto in modo che familiarizzassimo con l’idea che – fortunatamente – niente dura per sempre. Siamo a nostro agio con l’approccio al contemporaneo come temporaneo.
Cheap è un progetto che da anni ormai fa parte del tessuto urbano della città. È un qualcosa di ripetibile (o già ripetuto) in altre città? Cosa rende speciale il rapporto tra Cheap e Bologna?
 La nostra pratica è sicuramente ripetibile: crediamo però che ogni esperienza sia a sé e che il contesto in cui questa si sviluppa abbia un ruolo imprescindibile. Bologna, come altre città emiliane, ha una cultura molto forte dello spazio pubblico come spazio di cittadinanza, come luogo culturale e politico. Al di là di chi ci sostiene e ci segue, credo che negli anni il nostro lavoro sia stato percepito come gesto di cura nei confronti della città, come suggestione e invito al dialogo, come presenza immaginifica nelle strade.
La nostra pratica è sicuramente ripetibile: crediamo però che ogni esperienza sia a sé e che il contesto in cui questa si sviluppa abbia un ruolo imprescindibile. Bologna, come altre città emiliane, ha una cultura molto forte dello spazio pubblico come spazio di cittadinanza, come luogo culturale e politico. Al di là di chi ci sostiene e ci segue, credo che negli anni il nostro lavoro sia stato percepito come gesto di cura nei confronti della città, come suggestione e invito al dialogo, come presenza immaginifica nelle strade.
Alcune delle campagne di Cheap hanno destato scalpore e polemiche. Quale vi sareste aspettate e quale vi ha colpite di più?
Quando a giugno del 2020 abbiamo installato i poster di La lotta è FICA sapevamo che avremmo avuto il sostegno di chi riconosce la necessità di un cambio culturale del paradigma esistente, di chi pratica i femminismi, di chi contesta i lasciti coloniali, di chi sperimenta nuove forme di rappresentazione. Ma ci era anche molto chiaro che saremmo state attaccate ferocemente e funzionalmente da chi invece pratica un populismo becero come propria raison d’être, da chi produce ciclicamente discorsi d’odio e di indignazione retrograda. Ormai pare inevitabile essere attaccate, insultate e minacciate: è successo a noi e ad artistə che hanno lavorato con noi. La celebrazione all’interno dello spazio pubblico dei simboli del patriarcato, del privilegio maschile, del suprematismo bianco e della storia coloniale, è al centro di un dibattito mondiale: se in Italia la statua dedicata a Montanelli è stata oggetto di un’azione politica e di un gesto che noi riconosciamo come performativo, negli Stati Uniti tocca a Cristoforo Colombo.
 Nell’augurarci di poter finalmente assistere a un cambiamento reale del paradigma, ci siamo anche chieste in che termini ci è possibile partecipare. Cheap ha prodotto un intervento di arte pubblica che parla di femminismo, della connessione sistemica del potere nel generare funzionalmente sessismo e razzismo, della necessità di elaborare strumenti di decolonizzazione, di rappresentare corpi che orgogliosamente esulano dalla bianchezza o dall’eteronormatività o dalla visione binaria del genere. Così come sapevamo che c’è una fortissima resistenza a eliminare i simboli del privilegio, sapevamo che fare i conti con quelli della nostra liberazione non sarebbe stata una passeggiata. Un progetto che credevamo avrebbe creato molte tensioni (e che invece ha raccolto solo l’apprezzamento di chi lo ha capito condividendone i contenuti) è Ur-Fascismo, una serie di tavole disegnate da Pasquale Todisco e ispirate a una conferenza di Umberto Eco del 1995 tenuta alla Columbia University, il cui testo compare per la prima volta in Cinque scritti morali ed è stato recentemente ristampato con il titolo Il fascismo eterno. Il prefisso “Ur” viene preso in prestito dal tedesco e può essere tradotto in italiano con “antichissimo” o “originale”, per traslazione “perenne”: nella conferenza, Eco esplicitava un’idea di fascismo che è prima di qualsiasi cosa un fatto di cultura, «un modo di pensare e di sentire, una serie di abitudini culturali, una nebulosa di istinti oscuri e insondabili pulsioni». L’operazione di Cheap è quindi una rilettura della lezione del professore a confronto con il presente sociale e culturale del paese, rilettura che lascia a tratti esterrefatti per quanto risulta attuale e calzante l’analisi di Eco a distanza di più di vent’anni dalla sua enunciazione: vengono individuati tratti come il culto della tradizione e dell’azione per l’azione, il ricorso continuo alla volontà popolare, il sessismo, il rifiuto di ogni critica analitica, l’ossessione complottista, il ricorso a colpevoli esterni, l’appello a una classe sociale frustrata – ricorda niente?
Nell’augurarci di poter finalmente assistere a un cambiamento reale del paradigma, ci siamo anche chieste in che termini ci è possibile partecipare. Cheap ha prodotto un intervento di arte pubblica che parla di femminismo, della connessione sistemica del potere nel generare funzionalmente sessismo e razzismo, della necessità di elaborare strumenti di decolonizzazione, di rappresentare corpi che orgogliosamente esulano dalla bianchezza o dall’eteronormatività o dalla visione binaria del genere. Così come sapevamo che c’è una fortissima resistenza a eliminare i simboli del privilegio, sapevamo che fare i conti con quelli della nostra liberazione non sarebbe stata una passeggiata. Un progetto che credevamo avrebbe creato molte tensioni (e che invece ha raccolto solo l’apprezzamento di chi lo ha capito condividendone i contenuti) è Ur-Fascismo, una serie di tavole disegnate da Pasquale Todisco e ispirate a una conferenza di Umberto Eco del 1995 tenuta alla Columbia University, il cui testo compare per la prima volta in Cinque scritti morali ed è stato recentemente ristampato con il titolo Il fascismo eterno. Il prefisso “Ur” viene preso in prestito dal tedesco e può essere tradotto in italiano con “antichissimo” o “originale”, per traslazione “perenne”: nella conferenza, Eco esplicitava un’idea di fascismo che è prima di qualsiasi cosa un fatto di cultura, «un modo di pensare e di sentire, una serie di abitudini culturali, una nebulosa di istinti oscuri e insondabili pulsioni». L’operazione di Cheap è quindi una rilettura della lezione del professore a confronto con il presente sociale e culturale del paese, rilettura che lascia a tratti esterrefatti per quanto risulta attuale e calzante l’analisi di Eco a distanza di più di vent’anni dalla sua enunciazione: vengono individuati tratti come il culto della tradizione e dell’azione per l’azione, il ricorso continuo alla volontà popolare, il sessismo, il rifiuto di ogni critica analitica, l’ossessione complottista, il ricorso a colpevoli esterni, l’appello a una classe sociale frustrata – ricorda niente?
Ecco, noi eravamo pronte al peggio. Ma non successe nulla. Una critica d’arte si spiegò la cosa col migliore dei complimenti che potessimo aspettarci: «Era troppo sofisticato, i diretti interessati non potevano capirlo».
Foto di Margherita Caprilli

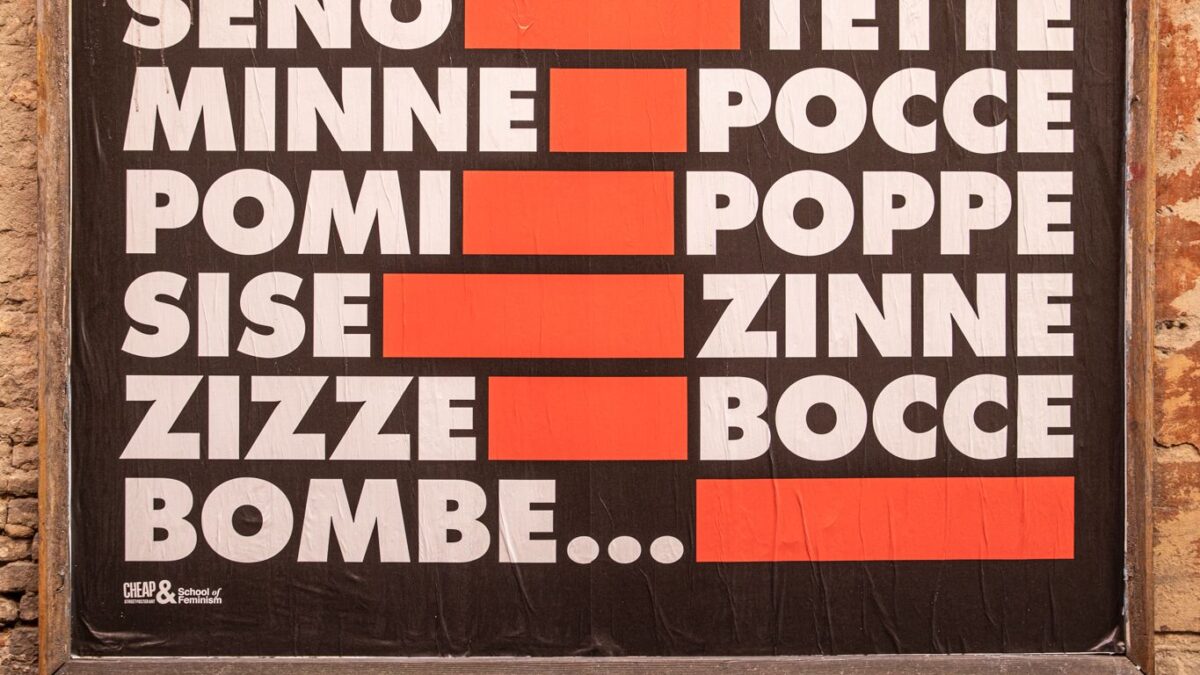
Perseguitaci