Raccontare la mia storia non fu mai facile quanto in quelle giornate dall’aroma di marijuana e brezza d’oceano. La latitudine di quella che all’epoca era casa dava una grande mano: Bay Area, un’ora e mezza da Castro, il campus da cui si sprigionò l’onda del ’68, a tutt’oggi popolato da ordinari in infradito che rifiutano le valutazioni numeriche in nome della didattica inclusiva. Eppure, è lì che vissi la più inverosimile uscita dall’armadio.
Nelle prime settimane dell’anno mi proposi per una posizione da assistente al dipartimento di Economia. Alla poesia (si fa per dire) del rapporto maestro-discente seguì la prosa di insegnare in inglese a duecento matricole alla volta. Una busta paga intessuta con l’ansia, che però teneva l’affitto lontano dall’orizzonte delle mie preoccupazioni.
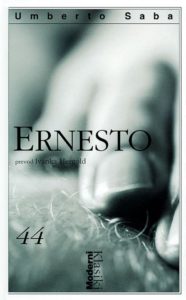 Fu per nonnismo, o ragionevole sacrificio – sei qua da poco, in un soffio volerai a casa – che, nell’ateneo più a sinistra delle Americhe, mi affidarono al macroeconomista più conservatore e al contempo iperliberista delle due coste. Messo piede nel suo ufficio mi si parò davanti il Libro di Mormon e, ai muri, le sue foto impegnato nell’investitura, giurando fedeltà a Jesus Christ e ai Santi degli Ultimi Giorni. Il piglio austero proiettava un’ombra minacciosa di riprovazione su ogni tentativo d’informalità. Pensai a quanto sarebbe stato lungo quel trimestre.
Fu per nonnismo, o ragionevole sacrificio – sei qua da poco, in un soffio volerai a casa – che, nell’ateneo più a sinistra delle Americhe, mi affidarono al macroeconomista più conservatore e al contempo iperliberista delle due coste. Messo piede nel suo ufficio mi si parò davanti il Libro di Mormon e, ai muri, le sue foto impegnato nell’investitura, giurando fedeltà a Jesus Christ e ai Santi degli Ultimi Giorni. Il piglio austero proiettava un’ombra minacciosa di riprovazione su ogni tentativo d’informalità. Pensai a quanto sarebbe stato lungo quel trimestre.
La vita fuori, naturalmente, era una festa continua: i miei otto coinquilini formavano di fatto una queer community degna di un circolo Arcigay; il fidanzatino dell’epoca era un tipo afroamericano che seguiva corsi di Feminist studies, e reputa Bernie Sanders troppo tenero con i borghesi. Istruito alla liturgia libertaria come un chierichetto, avevo fatto coming out praticamente anche con gli autisti dell’autobus del paesello. Non con Professor, ovvio, con il quale, faticosamente, restavo sul vago: la mascolinità impone spesso sciocche coreografie.
Furono settimane di grandi discussioni: honey, il personale è politico, la discriminazione non è che un ragionato riflesso della nostra pavidità. A un passo dalla fine del trimestre, l’intenzione maturò in azione e in un pallosissimo pomeriggio di lavoro mi decisi. Sul punto di rivelarmi, però, lui mi anticipò candidamente, dichiarando che una sera avrebbe avuto piacere di avermi a casa sua, così avrei conosciuto il marito e il piccolo Daniel.
Tirato giù dal palco in un momento, con l’occhio di bue puntato prima su di lui e poi sul mio sistema di equazioni con un sacco di soluzioni sconosciute. Il mio sguardo si consumò in un sorriso, mentre dicevo uno scialbo you know, I’m homosexual too, e solo allora notai sul tavolo, sopra a pile di paper, una copia dell’Ernesto di Umberto Saba. Un vocabolario condiviso consigliato senz’altro dal marito, che seppi poi essere un italianista.
A cena, in realtà, non ci andai: i tre finals da preparare di notte, il pacco di compiti da correggere, lo zaino e il clacson della vecchia Ford Cougar di Hannah che suonava di spring break, consumarono tutto il tempo a mia disposizione. O forse fu l’imbarazzo di un ventitreenne alle prese con i suoi pregiudizi (confesso: i turbocapitalisti agitano ancora i miei sogni, e i miei pasti).
pubblicato sul numero 38 della Falla – ottobre 2018


Perseguitaci