NUOVI SIGNIFICATI PER LA PAROLA LAVORO
di Marta Panighel
«Cosa vuoi fare dopo?». Ricordo quella stessa domanda ripetersi ogni volta che, finito il liceo, comunicavo alle figure adulte del mio piccolo mondo veneto che mi sarei iscritta a Lettere.
 «Lettere non ti fa trovare un lavoro vero». E io, pur essendo cresciuta in quel Nord-Est simbolo della vita dedicata al lavoro e del lavoro che è tutta la tua vita, avrei tanto voluto rispondere: non me ne frega un cazzo di lavorare. Era passato il 2008 e il mondo non era crollato, il capitalismo era acciaccato ma stava su e io pensavo: tanto c’è la crisi. È inutile sbattersi per cercare di diventare qualcuno, di fare carriera. Meglio dedicarmi a quello che amo. Per fortuna che c’è il femminismo, e quindi noi ossessionate dal nostro ombelico possiamo dire «parto da me» e fare finta che sia una questione politica. Poi ovviamente la politica c’entra, c’entra sempre.
«Lettere non ti fa trovare un lavoro vero». E io, pur essendo cresciuta in quel Nord-Est simbolo della vita dedicata al lavoro e del lavoro che è tutta la tua vita, avrei tanto voluto rispondere: non me ne frega un cazzo di lavorare. Era passato il 2008 e il mondo non era crollato, il capitalismo era acciaccato ma stava su e io pensavo: tanto c’è la crisi. È inutile sbattersi per cercare di diventare qualcuno, di fare carriera. Meglio dedicarmi a quello che amo. Per fortuna che c’è il femminismo, e quindi noi ossessionate dal nostro ombelico possiamo dire «parto da me» e fare finta che sia una questione politica. Poi ovviamente la politica c’entra, c’entra sempre.
Non ho mai voluto lavorare, a parte da piccolissima quando pensavo di voler fare la maestra, – come mia nonna, – e anche adesso mentre scrivo un articolo sul lavoro mi sembra di non essere adatta, di non aver mai lavorato veramente. Faccio un dottorato (che mica è un lavoro, cosa vuoi fare dopo?) e prima ho sempre svolto lavori precari – a chiamata, in nero, stagionali – senza dimenticare gli stage mal pagati e le alternanze scuola-lavoro i con accluse molestie da parte del vigile urbano del comune. #youtoo?
You don’t hate work, you hate capitalism
Abbiamo attraversato/stiamo attraversando una pandemia globale che, in Italia, ci ha fatto fare i conti con problemi in parte già conosciuti, ma dei quali abbiamo visto le conseguenze più disastrose. Ne cito solo due: da una parte, lo smantellamento sistematico della sanità pubblica che, con quasi 40 miliardi di tagli, definire impreparata ad affrontare un’epidemia è oltre l’eufemismo. Dall’altra parte, la metodica costruzione del nemico per distrarre l’opinione pubblica dalle scelte criminali, di oggi e di ieri, di governi e amministrazioni locali. Da marzo a oggi la colpa della diffusione dell’epidemia di Covid-19 è stata scaricata contro: i runner, la movida, la Sardegna, i poveri delle periferie, i migranti. E intanto alcune aziende non hanno mai chiuso, produttività über alles.
E chissenefrega se le misure di sicurezza non sono adeguate a garantire la salute di chi lavora, chissenefrega se i nuovi focolai più che a causa dellɘ turistɘ continuano a scoppiare nelle grandi catene produttive. La crisi ci insegna che dobbiamo essere ancora più gratɘ ai padroni che ci assumono con condizioni sempre più quotate al ribasso, sempre più ricattatorie, perché c’è sempre meno lavoro e devi ritenerti fortunatɘ ad averlo. E allora grazie, grazie, grazie che ci permettete di lavorare finché morte non ci separi, e che la smettessero le zecche rosse o fucsia di tenere il conto degli incidenti nelle fabbriche, delle malattie sviluppate a norma di legge, dei morti nei o verso i campi, delle sex workers ammazzate, dellɘ riders investitɘ, delle mogli massacrate. Questa non è l’ora di protestare, è l’ora degli hashtag che invitano a rialzarsi e ricominciare, l’ora di ringraziare e di tornare a lavorare.
Oppure è l’ora di non chiederci più «che lavoro fai [per vivere]?» ma invece «come fai a sopravvivere al lavoro?».
Si nosotras paramos, se para el mundo
Tra gli slogan del movimento femminista globale, questo mi fa sempre venire i brividi: se ci fermiamo noi, si ferma il mondo. Dal 2017 lo sciopero, a lungo prerogativa dei sindacati, forma di interruzione del solo cosiddetto lavoro produttivo, è stato risignificato dalle femministe che lo hanno reso uno strumento della lotta contro la violenza maschile e di genere. Ma all’epoca del lavoro sfruttato, precario, del non-lavoro, come si fa a scioperare? Come si fa a non cedere al ricatto del lavoro? Come si passa dalla rappresentazione dello sciopero a far tremare le fondamenta di un sistema che ci opprime?
 Intanto, nominando tutte le forme di lavoro dal quale vogliamo scioperare: il lavoro riproduttivo, il lavoro di cura, il lavoro dei generi. Trovando forme e strategie nuove, frivole, collettive, mutualistiche per rendere visibile il lavoro invisibile quotidiano, adottando una prospettiva transfemminista trasversale, costruendo alleanze intersezionali. Lo sciopero dal lavoro riproduttivo e di cura è stato quello che ha messo più alla prova il movimento transfemminista: nell’epoca della distruzione del welfare, del razzismo istituzionale (dalle sanatorie leghiste a quelle democratiche), a svolgere il cosiddetto lavoro sporco sono spesso donne migranti. Che le femministe bianche interrompano per un giorno la riproduzione non risolve il problema di chi – povera, razzializzata, senza contratto, vittima del ricatto dei documenti – non può materialmente sottrarsi da quel lavoro. Soprattutto, anche una volta raggiunta l’utopia del reddito di autodeterminazione, quel lavoro sporco dovrà pur farlo qualcuno, e l’errore di subappaltarlo, complici l’imperialismo capitalista globale e il razzismo istituzionale, a chi è più oppressɘ di noi sarà meglio non ripeterlo.
Intanto, nominando tutte le forme di lavoro dal quale vogliamo scioperare: il lavoro riproduttivo, il lavoro di cura, il lavoro dei generi. Trovando forme e strategie nuove, frivole, collettive, mutualistiche per rendere visibile il lavoro invisibile quotidiano, adottando una prospettiva transfemminista trasversale, costruendo alleanze intersezionali. Lo sciopero dal lavoro riproduttivo e di cura è stato quello che ha messo più alla prova il movimento transfemminista: nell’epoca della distruzione del welfare, del razzismo istituzionale (dalle sanatorie leghiste a quelle democratiche), a svolgere il cosiddetto lavoro sporco sono spesso donne migranti. Che le femministe bianche interrompano per un giorno la riproduzione non risolve il problema di chi – povera, razzializzata, senza contratto, vittima del ricatto dei documenti – non può materialmente sottrarsi da quel lavoro. Soprattutto, anche una volta raggiunta l’utopia del reddito di autodeterminazione, quel lavoro sporco dovrà pur farlo qualcuno, e l’errore di subappaltarlo, complici l’imperialismo capitalista globale e il razzismo istituzionale, a chi è più oppressɘ di noi sarà meglio non ripeterlo.
C’è del lavoro da fare
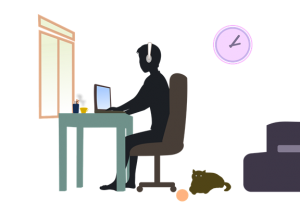 Con gli anni, la politica e le compagne, mi è venuta voglia di risignificare la parola lavoro, come tutti gli insulti che la comunità LGBT+ ha ribaltato e fatto propri – come con il queer prima che venisse assorbito, ridigerito e risputato fuori come mera inclusione del diverso in un mondo che continua a fare schifo. E non parlo della retorica neoliberista dell’ama-il-tuo-lavoro&co., né di diversity management o del buon cuore di aziende e terzo settore che ti fanno sentire in famiglia per farti sputare meglio il sangue (noi dovremmo saperlo bene, non è proprio quello che fanno le famiglie?). E non parlo neanche del capitalismo etico, che sappiamo non può esistere come non possono esistere le guerre umanitarie o la violenza per troppo amore. Vorrei ribaltarla perché il lavoro non fa schifo in assoluto. Fa schifo dentro un sistema che si fonda sull’intersezione tra oppressioni per il beneficio di pochi.
Con gli anni, la politica e le compagne, mi è venuta voglia di risignificare la parola lavoro, come tutti gli insulti che la comunità LGBT+ ha ribaltato e fatto propri – come con il queer prima che venisse assorbito, ridigerito e risputato fuori come mera inclusione del diverso in un mondo che continua a fare schifo. E non parlo della retorica neoliberista dell’ama-il-tuo-lavoro&co., né di diversity management o del buon cuore di aziende e terzo settore che ti fanno sentire in famiglia per farti sputare meglio il sangue (noi dovremmo saperlo bene, non è proprio quello che fanno le famiglie?). E non parlo neanche del capitalismo etico, che sappiamo non può esistere come non possono esistere le guerre umanitarie o la violenza per troppo amore. Vorrei ribaltarla perché il lavoro non fa schifo in assoluto. Fa schifo dentro un sistema che si fonda sull’intersezione tra oppressioni per il beneficio di pochi.
Una delle cose che ci ha mostrato la pandemia è che il lavoro politico solidale e mutualistico è uno dei pochissimi modi per rispondere alle contraddizioni di questo tempo infame, per trovare nuove strade che ci liberino e ci salvino tuttɘ insieme. Dalle raccolte di pc per studenti, alle collette per le sex workers, dalla distribuzione delle spese al baby-sitting solidale, il tempo discretamente sospeso del lock down per assurdo non ci ha fatto rinchiudere in noi stessɘ ma ci ha proiettato verso comunità vecchie o nuove. Chi aveva (tempo, denaro, capacità o beni materiali), dava, chi aveva bisogno, chiedeva. Non parlo di romanticizzare la quarantena a posteriori, parlo di non lasciar cadere quel desiderio di politica e di collettività che abbiamo fatto di tutto per mantenere e (ri)costruire anche quando era più difficile. Parlo di lavorare sui nostri desideri di liberazione, per non lasciare che siano sradicati dal ritorno alla normalità, ma anzi, per farli germogliare ancora e ancora.
Pubblicato sul numero 58 della Falla, ottobre 2020


Perseguitaci