Fabrizio Acanfora è uno scrittore e attivista autistico, oltre che musicista e coordinatore del Master in Musicoterapia presso l’Università di Barcellona. Ha vinto il Premio nazionale di divulgazione scientifica del CNR nel 2019 per il suo libro Eccentrico. In occasione della sua presentazione al Gender Bender Festival, l’abbiamo intervistato in merito al suo ultimo libro, In altre parole. Dizionario minimo di diversità, un saggio sull’uso del linguaggio relativo alle minoranze pubblicato da effequ.
Per quale motivo hai deciso di scrivere un libro incentrato sul linguaggio e perché hai scelto proprio la forma del dizionario?
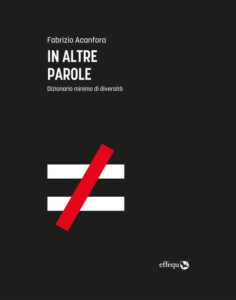 Fin da bambino ho sempre avuto l’idea che quello che si dice si traduce in maniera concreta nella vita delle persone, forse perché come categorie stigmatizzate ci accorgiamo da subito di come ci chiamano: diventa per noi una cosa identitaria. Poi dopo il primo libro, durante conferenze o incontri, soprattutto parlando di come le persone autistiche preferiscono essere definite, si finiva a discutere di linguaggio anche riguardo ad altre categorie. Mi sono reso conto che per primo non sapevo moltissime cose di determinati mondi, perciò ho cominciato a informarmi e leggere tantissimo. Così ho pensato a un libro semplice in cui spiegare le cose in maniera più facile possibile, e per fare questo ho scelto di parlare di diversità partendo proprio da quelle parole che spesso vengono fraintese o usate in maniera impropria.
Fin da bambino ho sempre avuto l’idea che quello che si dice si traduce in maniera concreta nella vita delle persone, forse perché come categorie stigmatizzate ci accorgiamo da subito di come ci chiamano: diventa per noi una cosa identitaria. Poi dopo il primo libro, durante conferenze o incontri, soprattutto parlando di come le persone autistiche preferiscono essere definite, si finiva a discutere di linguaggio anche riguardo ad altre categorie. Mi sono reso conto che per primo non sapevo moltissime cose di determinati mondi, perciò ho cominciato a informarmi e leggere tantissimo. Così ho pensato a un libro semplice in cui spiegare le cose in maniera più facile possibile, e per fare questo ho scelto di parlare di diversità partendo proprio da quelle parole che spesso vengono fraintese o usate in maniera impropria.
Da un punto di vista metalinguistico, com’è stato scrivere questo libro? Hai dovuto fare riflessioni particolari sui termini e le forme da usare?
Essendo un libro che parla di diversità era fondamentale che trasparisse un’attenzione linguistica verso tuttǝ. Il libro impiega lo schwa, uso che è partito da Vera Gheno: abbiamo fatto una diretta pochi giorni fa in cui abbiamo ripetuto ancora che non si tratta di una norma prescrittivista ma di una proposta che vuole stimolare parlanti e lettorǝ. Per me, è una forma di rispetto. Devo dire che durante la scrittura, preso dall’entusiasmo, l’avevo inserito dappertutto; poi in fase di editing è stato sapientemente dosato da Silvia Costantino di effequ. Nel libro si parla di categorie di persone di creazione abbastanza recente (anche la categoria “omosessuale” ha poco più di duecento anni). Cito spesso Ian Hacking che parla di looping effect, ovvero il fenomeno per cui la società crea una categoria definendola con un nome, e una persona che ne fa parte in qualche modo è condizionata da questa definizione, però a sua volta la persona stessa influenzerà la categoria a cui appartiene. Attraverso il linguaggio creiamo dei modelli, che influenzano il modo che abbiamo di percepire le cose (pensiamo agli stereotipi di genere), ed è per questo che secondo me è così importante.
Dalla tua prospettiva di autistico e omosessuale, quali sono le parole che accomunano le identità LGBTQ+ e la neuroatipicità? Come rientra in questa intersezione quella che definisci «normodiversità»?
 Penso subito alle tante identità che restano nascoste: ad esempio conosco moltissime persone autistiche, anche con diagnosi mediche, che magari non fanno coming out in ufficio per non avere problemi. Oggi si parla molto di diversità, dagli ambienti lavorativi a quelli politici, ma con un errore fondamentale: si intende la diversità come una sottocategoria della normalità. In realtà diversità equivale a varietà, che è la condizione originale della natura umana, mentre la normalità è un concetto artificiale diffuso solo dal 1800. Molte delle campagne per l’inclusione, ad esempio delle aziende, sono rivolte solo ad alcuni tipi di diversità, che vengono normalizzate sul modello di quello che è considerato appunto “normale”. In questo modo alle differenze si sostituiscono tante piccole normalità (da qui, la normodiversità), che però escludono le minoranze nelle minoranze, oppure coloro che non vogliono o non possono conformarsi a queste norme, come una persona autistica che non è un genio del computer o magari non usa il linguaggio verbale per esprimersi, oppure una persona omosessuale che non vuole sposarsi e preferisce avere tantǝ partner.
Penso subito alle tante identità che restano nascoste: ad esempio conosco moltissime persone autistiche, anche con diagnosi mediche, che magari non fanno coming out in ufficio per non avere problemi. Oggi si parla molto di diversità, dagli ambienti lavorativi a quelli politici, ma con un errore fondamentale: si intende la diversità come una sottocategoria della normalità. In realtà diversità equivale a varietà, che è la condizione originale della natura umana, mentre la normalità è un concetto artificiale diffuso solo dal 1800. Molte delle campagne per l’inclusione, ad esempio delle aziende, sono rivolte solo ad alcuni tipi di diversità, che vengono normalizzate sul modello di quello che è considerato appunto “normale”. In questo modo alle differenze si sostituiscono tante piccole normalità (da qui, la normodiversità), che però escludono le minoranze nelle minoranze, oppure coloro che non vogliono o non possono conformarsi a queste norme, come una persona autistica che non è un genio del computer o magari non usa il linguaggio verbale per esprimersi, oppure una persona omosessuale che non vuole sposarsi e preferisce avere tantǝ partner.
Nel capitolo Privilegio parli del prototipo di persona privilegiata identificandola come maschio bianco, eterosessuale, neurotipico e non disabile. Perché non usi il termine abile?
In quel punto ho scelto la definizione di non disabile perché è molto più forte e non passa inosservata. Nel libro ho illustrato come il concetto di abilità sia estremamente effimero: intanto con la vecchiaia perdiamo molte “abilità” e diventiamo disabili, ma anche se ti rompi una gamba per qualche mese puoi sperimentare una situazione di disabilità. La condizione di abilità è transitoria, mentre “disabilità” è un termine identitario, e per questo è così potente.
Nella premessa Contro l’inclusione e nel rispettivo capitolo metti in discussione il concetto di inclusività. Da cosa deriva l’idea di «convivenza delle differenze»?
L’idea della convivenza delle differenze l’avevo gettata lì senza pensarci troppo in un saggio sull’inclusione al lavoro delle neurodivergenze, che avevo passato a Vera Gheno per farle dare una lettura, e questo concetto le è piaciuto molto. Parlare di inclusione implica che la maggioranza include la minoranza, alla quale concede come un permesso per entrare, per diventare in termini matematici un sottoinsieme dell’insieme. Si dice che l’inclusione è un passo avanti rispetto all’integrazione, la quale richiede un’assimilazione nel gruppo e che ovviamente è a sua volta meglio della segregazione. Con l’inclusione la maggioranza (che condivide caratteristiche più frequenti) si prende il diritto di decidere chi può far parte o meno della società. Ecco perché parlo di convivenza, perché è un termine neutro che non implica rapporti di potere: certo è una convivenza attiva, perché per funzionare ha bisogno che i singoli individui si responsabilizzino nei confronti dell’altrǝ. Chiaramente non voglio dire che non si deve più usare la parola inclusione, ma l’idea di convivenza delle differenze è solo un’altra proposta per riflettere sul linguaggio che usiamo correntemente, e che magari sarà superata da un termine più efficace.
Immagine in evidenza da tropismi.it, immagine nel testo da ibs.it


Perseguitaci