Verona, 30 aprile 2025: presso l’Aula Magna di Santa Marta dell’Università di Verona, si è tenuto l’incontro For an Ethics of Vulnerability: Judith Butler and Adriana Cavarero in Dialogue, sul tema appunto dell’etica della vulnerabilità. Abbiamo chiesto all’autor* di poter pubblicare sulla Falla questi appunti, dai suoi profili social, su un dibattito tra due visioni ben distanti: da un lato Butler, tra le più autorevoli teoriche queer e transfemministe, dall’altro Cavarero, caposaldo della teoria della differenza sessuale.
- La redazione
Di alleanze e fallimenti: un appunto personale sul dialogo (mancato) tra Butler e Cavarero
*(e noi: nessuna domanda dal pubblico chiamato “fascista” da una docente presente quando delle voci si sono sollevate, evento fatto terminare 10 minuti prima)
Ci sono momenti in cui si capisce che una parola, un concetto, perfino un gesto mancato, può spalancare un abisso. A Verona, il 30 aprile, durante il dialogo tra Judith Butler e Adriana Cavarero, quell’abisso si è fatto visibile. Aveva i contorni della paura, e forse anche della delusione. O almeno, io l’ho vissuto così.
Il confronto – tanto atteso – avrebbe dovuto aprire uno spazio di possibilità tra pensiero femminista e istanze queer. Ma più che una conversazione, è sembrato un corpo a corpo tra linguaggi che non riescono più a riconoscersi. Butler ha tentato di rilanciare una visione dell’alleanza fondata sulla vulnerabilità, sull’esposizione, sull’idea che ascoltare significhi lasciarsi trasformare. Ma la risposta, soprattutto da parte di Cavarero, è sembrata inchiodata a una nostalgia per corpi e identità “sicure”, perfino protette da quella stessa vulnerabilità che a parole si dice di voler valorizzare.
Cavarero ha parlato di vulnerabilità come relazionalità, come dipendenza. Ma quando ha detto, per più volte, che «siamo tutti nati da una donna», mi sono chiestə cosa avrebbe risposto mia figlia, nata da una persona non binaria. Cosa avrebbe risposto chiunque di noi che ha imparato che il corpo non è un dato semplice, non è una funzione riproduttiva. E, francamente, non si può invocare Vita activa per sostenere un’idea tanto biologizzante della nascita: Arendt non parlava di “donne” ma di umanità, di un’agency che si opponeva a un mondo devastato dai crimini del Novecento, da Auschwitz e Hiroshima. Il “miracolo della nascita” in Arendt non è biologico, ma politico: è l’irrompere di una nuova possibilità nel mondo. Usarla per sostenere un’essenzializzazione della maternità è una forzatura che tradisce il suo pensiero.
La verità è che a Verona non c’è stato solo disaccordo. C’è stata paura. Paura di perdere il significato di “donna”, paura che la genealogia femminista venga cancellata.
“Non chiamatemi persona con utero!”, “non vogliamo inclusione ma ognuno deve stare con la sua parzialità” (ovviamente tutti tranne la Donna evidentemente) – cit. Cavarero.
Ma queste paure non nascono dal nulla: sono il prodotto di fantasmi retorici costruiti ad arte dal discorso patriarcale e reazionario. Lo stesso che ha creato l’ideologia gender, che ha attaccato gli studi critici sulla razza, il pensiero decoloniale, che ha trasformato il woke in una barzelletta per benpensanti bianchi. Lo stesso discorso che ha ridotto le istanze trans a una finta guerra tra donne, come se esistesse una minaccia strutturale da parte delle donne trans alle donne assegnate femmine alla nascita. È una narrazione che serve al potere, non alla libertà.
Eppure anche alcune femministe vi si sono rifugiate. Forse poche, ma rumorose, privilegiate e molto visibili. Ed è da questo rifugio che lanciano accuse a chi – come me, come tantə – chiede solo di non essere esclusə da un discorso che dovrebbe parlarci di liberazione.
Nessuno vuole cancellare la parola donna. Nessuno vuole impedire a una femminista di chiamarsi tale. Ma quando diciamo “persone con utero” non lo facciamo per cancellare, bensì per includere. Lo facciamo perché sappiamo cosa significa essere respintə da una struttura sanitaria, da una legge, da una parola.
A un certo punto del dialogo, Cavarero ha proposto un’immagine dell’alleanza come cacofonia, come pluralità dissonante che però non rinuncia al legame. Butler, che aveva parlato di “agire in concerto”, ha accolto la provocazione, ma non senza una certa ambiguità: «se vuoi, possiamo chiamarla cacofonia», ha detto. Io, però, non riesco a pensarla così. Una cacofonia che non si ascolta è solo rumore. E ascoltare – davvero – implica essere dispostə a cambiare. Se non ti lasci trasformare, non stai ascoltando: la relazionalità è compromissione, non solo contatto. E allora mi chiedo se non sia questo, davvero, il nodo politico: la trasformabilità. Per Butler, la vulnerabilità è apertura. Per Cavarero, pare essere ferita da proteggere. E da lì, temo, non può nascere solidarietà. Perché la solidarietà non è compatibilità, ma possibilità di mutua alterazione.
A Verona, io credo, si è assistito a un fallimento. Ma non lo dico con disprezzo. Lo dico con la consapevolezza che il fallimento può essere generativo, se lo riconosciamo, se ci lasciamo interrogare. Il pensiero queer ha fatto del fallimento una forza politica. Come scrive Jack Halberstam in The Queer Art of Failure, il fallimento è un’arte:
una forma di rifiuto alle logiche dominanti del potere e della disciplina, […] una forma di critica. Come pratica, il fallimento riconosce che le alternative sono già inscritte nel dominante e che il potere non è mai totale né coerente.
(It is an artform, a way of refusing to acquiesce to dominant logics of power and discipline and […] a form of critique. As a practice, failure recognizes that alternatives are embedded already in the dominant and that power is never total or consistent., p. 88)
Allora forse da questo fallimento possiamo ripartire. Non per sanarlo, ma per abitarlo. Perché è lì, nell’inciampo, nella frattura, nella dissonanza che non si lascia ordinare, che può nascere un altro modo di stare insieme.

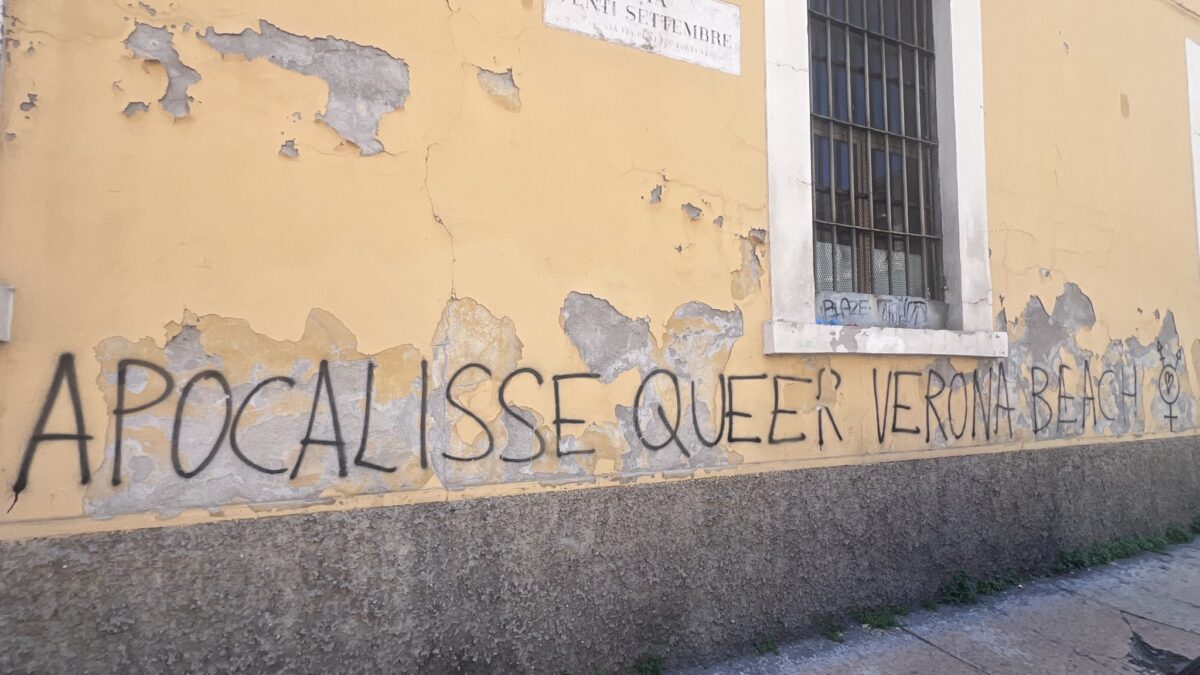

Perseguitaci