Il lato oscuro dell’attivismo digitale
di Pier Paolo Scarsella
Il 26 Gennaio scorso il sito We Are Social ha pubblicato il report Digital 2017 in cui analizza le tendenze e le ore trascorse sul web da parte dei cybernauti di tutto il mondo. Sul panorama italiano ad accedere a un qualsiasi canale digitale sono circa 39,21 milioni di persone su una popolazione di 59,80 milioni. Interessante è la quantità di tempo che un utente medio trascorre giornalmente su Internet, in particolare su social network come Facebook e Twitter, che, tra accessi via computer e smartphone, supera largamente la soglia delle otto ore. Inoltre, del tempo trascorso sulla rete, solo il 13% è dedicato all’informazione del quale il 73% tramite social.
Se questi dati singolarmente dicono poco, nel loro complesso forniscono alcuni spunti di riflessione, da quando anche casa Zuckerberg ha subito l’invasione di quello che oggi è conosciuto come “attivismo digitale”. Dalla propaganda animalista di dubbi imprenditori alla presentazione di interi programmi politici a colpi di tweet passando per le cornici di Facebook, il web sembra dare a ognuno quel piccolo spazietto per dire la propria su una determinata causa.
L’articolo Perché la rivoluzione non si farà twittando del sociologo Malcolm Gladwell evidenzia i punti deboli dell’attivismo digitale che nella maggioranza dei casi si traduce in un “overflow informativo”, generando fenomeni come lo slacktivism e il clicktivism, ovvero la tendenza ad aprire un link o a lasciare un “mi piace” senza che ci sia reale interesse nei confronti della causa. Ciò è favorito dal fatto che le proteste web sono efficaci solo nel breve periodo poiché pongono l’attenzione della sfera pubblica su una determinata situazione, ma questa si esaurisce nel giro di poco, soppiantata dall’arrivo di un altro “overflow informativo”. Se, magra consolazione, possiamo considerare queste lotte telematiche come un segno positivo di informazione e partecipazione alla causa, di dubbia utilità è invece un altro caposaldo dell’attivismo digitale: la petizione online.
Negli ultimi anni sono fiorite centinaia di piattaforme che con la mission spot un click per cambiare il mondo, sembrano dare la possibilità di prendere decisioni come in un’utopica democrazia diretta. Se la confezione dei siti invoglia a sostenere le cause presenti sulle piattaforme, basta dare un’occhiata approfondita per capire che qualcosa non funziona. Un esempio: stando a quanto dichiara Change.org è merito della petizione sul suo sito se Renzi si è dimesso in seguito al referendum del 4 Dicembre scorso. Capite? Indagando più a fondo, si scopre inoltre che quelli che dovrebbero essere siti di attivismo partecipato sono invece delle aziende con degli utili. I ricavati provengono dagli stessi sostenitori delle petizioni, secondo due formule ben precise: vendita dei dati personali degli iscritti per scopi pubblicitari e donazioni dirette. Se la richiesta di trattamento dei dati personali “da parte di terzi” ormai non la legge più nessun* – nonostante il principale cruccio moderno sia la tutela della privacy – la situazione diventa più delicata quando si parla di donazioni.
Se la confezione dei siti invoglia a sostenere le cause presenti sulle piattaforme, basta dare un’occhiata approfondita per capire che qualcosa non funziona. Un esempio: stando a quanto dichiara Change.org è merito della petizione sul suo sito se Renzi si è dimesso in seguito al referendum del 4 Dicembre scorso. Capite? Indagando più a fondo, si scopre inoltre che quelli che dovrebbero essere siti di attivismo partecipato sono invece delle aziende con degli utili. I ricavati provengono dagli stessi sostenitori delle petizioni, secondo due formule ben precise: vendita dei dati personali degli iscritti per scopi pubblicitari e donazioni dirette. Se la richiesta di trattamento dei dati personali “da parte di terzi” ormai non la legge più nessun* – nonostante il principale cruccio moderno sia la tutela della privacy – la situazione diventa più delicata quando si parla di donazioni.
Diversi siti consentono agli utenti iscritti di eseguire dei versamenti per migliorare la visualizzazione di una petizione, alla stregua di un annuncio di vendita di merce di seconda mano, su altri invece figura come un aiuto all’ente promotore. Inoltre, nel caso in cui la somma delle donazioni non sia sufficiente agli scopi prefissati, il sito si riserva il diritto di disporne come meglio crede. Se fin qui sia formalmente tutto lecito, bisogna ricordare che dal punto di vista legale queste petizioni sono inutili. In Italia secondo la legislazione vigente l’unico modo per inoltrare una petizione online, valida, è scrivere una mail all’indirizzo del Parlamento allegando un documento riconosciuto. Nonostante ciò, il numero di petizioni cresce esponenzialmente e c’è da chiedersi come mai questo sia possibile. Come si può credere che la messa al bando di un pesticida dalle coltivazioni italiane sia merito di una petizione virtuale e non una conseguente riforma dovuta a una sanzione europea? Forse è il caso di porsi una domanda: siamo davvero sicur* che un “mi piace” o un click produca un passo in avanti per una società migliore?
pubblicato sul numero 25 della Falla – Maggio 2017

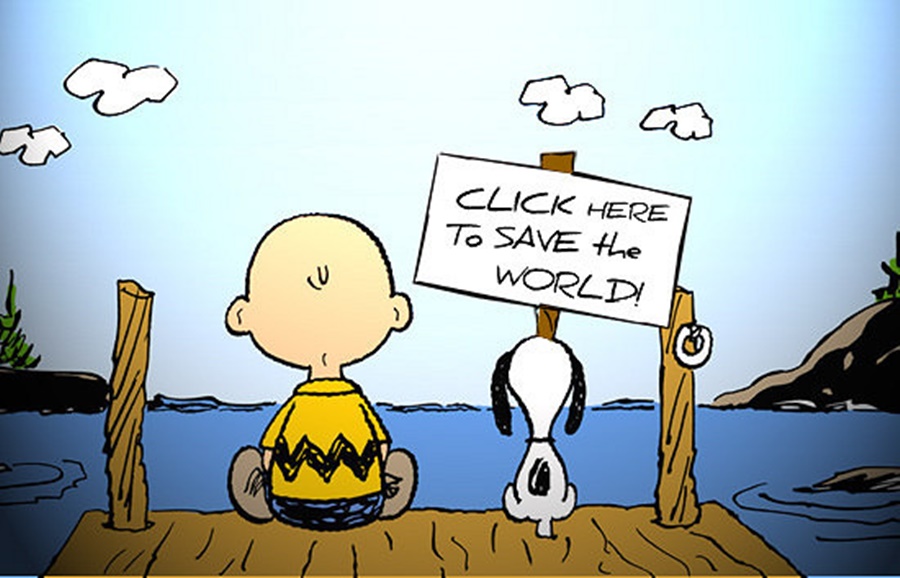
Perseguitaci