Perché siamo più figh*? Perché siamo alternativ*? Perché, siamo radical chic?
Diamanda Gàlas ha sparigliato le carte come al solito, ammantata in una scenografia scarna ed elegante, quasi nel dubbio di un simbolismo volutamente lasciato al caso o esplicito nel richiamare la bassezza alla quale può scendere l’essere (in)umano e la risalita della redenzione.
Due semplici scale lasciate lì in penombra, sulle quali sì è srotolata la nudità delle quattro ottave della sua voce e del solo pianoforte, a palesare ancora una volta, se mai ce ne fosse stato bisogno, l’appartenenza a un’altra dimensione espressiva.
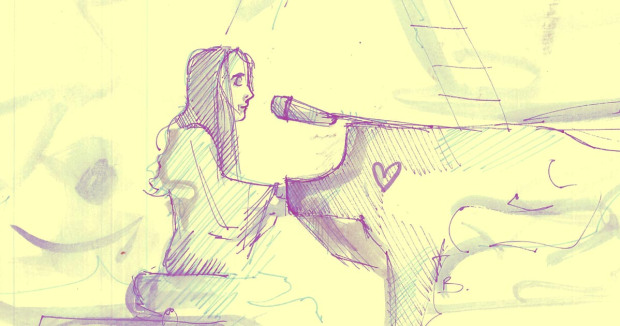
Vederla sinceramente emozionata per l’accoglienza tributatale dall’Auditorium Manzoni è stato, a sua volta, abbastanza emozionante. Quanto il suo battersi forte, rabbioso quasi, a scaricare l’impossibilità di articolare una piccola risposta in una lingua non padroneggiata nell’uso quotidiano ma fatta propria nel recitato o cantato.
“Il cuore!”. Colpirsi proprio lì per ringraziare. Colpirsi dove è andata a colpire con il recital portato in scena.
Per una volta la Serpenta ha tenuto legato il demone della performer e ha recuperato la semplicità di un termine ormai desueto. Un recital di versi, con un razionale tematico doloroso e di dannazione, da sempre sua area di interesse e sensibilità, se non di militanza, eppure mai ripetitivo o fine a se stesso.
Un recital, certo non di proposte mainstream per quanto, magari, sull’impegnato ma una scaletta di versi proposta con il magnetismo e la capacità affabulatoria della chansonnier diabolica. Vi aspettate la devastazione sonora con la voce a rassicurare le anime devote dell’estetica Gàlas? E lei invece si presenta con un’apertura a cappella che annichilisce per perfezione formale e purezza cristallina della voce.
Soprattutto la potenza di questo gioiello, che non è mai “vulgar display of power” ma magistero esoterico che cesella lirismi spericolati e diplofonie su vassoi d’argento salvo poi trascinarti in un paio di battute, e senza che te ne renda conto, in un rassegnato tre quarti, pesante e cupo come il growling ante litteram della voce, tra un Tom Waits d’annata e un Max Cavalera maestro di Sepultura.
E quando la tua resistenza emotiva è straziata, il tuo trucco waterproof si diluisce attonito nello Stige delle lacrime che ti segnano, eccola che ti prende per mano e ti canta la musica di sofferenza e redenzione per definizione, ti riporta nei tempi pari del blues, dilatato e rigirato che quasi non ti accorgi che la progressione armonica è pur sempre quella dannatissima e fottutissima I-IV-V.
Non fai in tempo a riposizionarti che lenta e inesorabile riprende a scavarti dentro, a risucchiarti nell’ipnosi di frammenti armonici sospesi, echi d’oriente e la voce inquietante che ti ricorda che la sacerdotessa è comunque sempre lei e non ti puoi perdere nelle risonanze della cordiera del pianoforte, innescate con esoterica sapienza.
Eppure c’è dolcezza in questo senso di dolore e sofferenza. Di tragedia. C’è il dolore dei forti e dei giusti. Piegati, vilipesi, violentati e annullati, fisicamente o meno, ma c’è dolcezza, non svenevole buonismo ma la dolcezza di chi soffre e vive con il Cuore. Come molte di noi, persone LGBT+.
Forse è anche per questo che la Serpenta ha un posto nel nostro cuore, indipendentemente dalla sua incazzatura con dio per non averla fatta lesbica.
pubblicato sul numero 14 della Falla, aprile 2016
immagine realizzata da Bruma e Miele

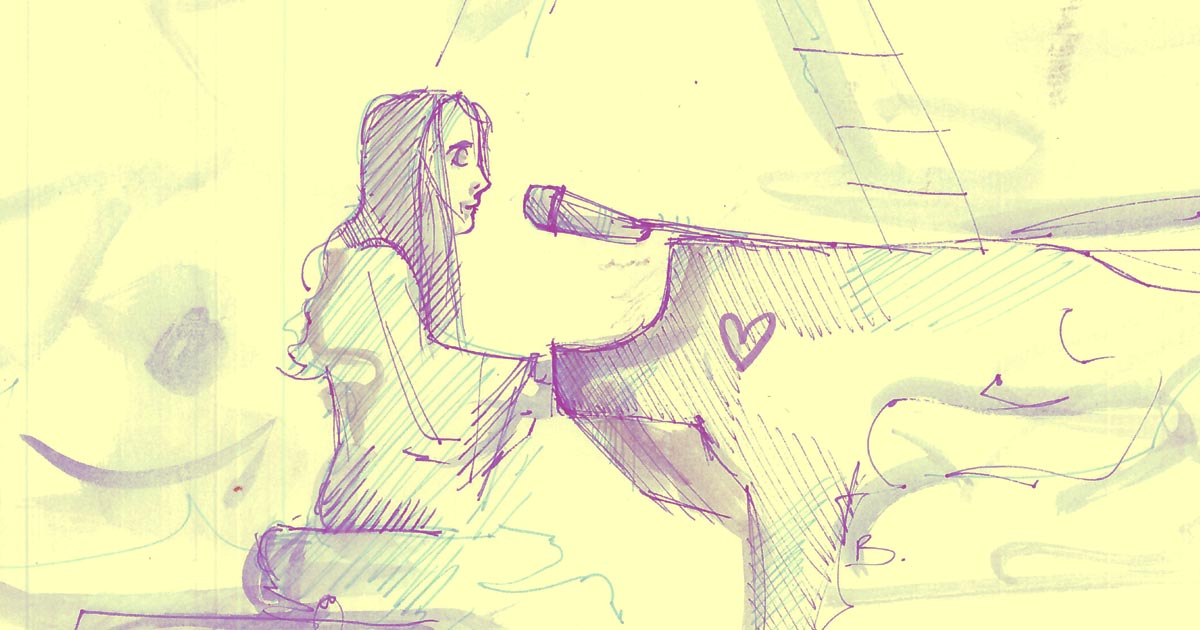
Perseguitaci